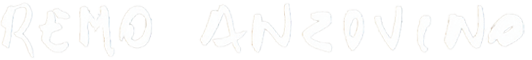Galilei nasce dall’idea di utilizzare quell’icona che oggi è di fatto il grande scienziato italiano con un fine specifico e ben chiaro: parlare di altro trascendendo Galilei. La sua vita parla di un grande ingegno che convive con le difficoltà di un uomo in profonda crisi, costretto ad abiurare di fronte ai giudici le proprie teorie per paura del rogo, della morte. Una notte ho immaginato che vivesse oggi, usasse lo smartphone, i social, le e-mail. L’ho immaginato nella sua stanza guardare le stesse stelle che osservava allora; ho giocato ad essere io quel Galilei oggi e raccontarlo in musica, immerso in una realtà che impone velocità di pensiero e di azioni impensabile anche solo venti o quindici anni fa, ma che al contempo sfida tutti noi a rimanere umani. Ho immaginato quell’uomo che guarda le stelle, e più che cercare risposte con l’osservazione scientifica, si pone domande che noi, mi sembra, non sappiamo più porci. È nata così una melodia volutamente elementare che per scarnificazione dell’elemento tematico diventa una metafora dello sguardo acuto, penetrante, essenziale di Galilei. L’osservazione delle stelle (da cui detto per inciso nascono anche tutte le composizioni di questo disco) allora come oggi incanta, non solo per la bellezza del firmamento in sé ma anche in quanto dalle stelle l’uomo ha saputo creare simboli universali che parlano del suo pensiero, delle sue domande, delle sue scoperte. Osservando quello stesso firmamento, immaginandomi Galileo, mi è venuto da pensare che ognuno di noi ha in un modo o in un altro abiurato; ha affermato almeno una volta che la terra è ferma e che il sole le ruota intorno. Come? Rinnegando per paura almeno uno dei propri più grandi desideri; per questa ragione, all’improvviso, la musica si ferma in un accordo sospeso, quasi dissonante. Riparte poi in un modo assolutamente inaspettato perché al pianoforte, strumento così “ontologicamente” occidentale, si unisce il duduk armeno, uno strumento magnifico che raccolta mondi così differenti e lontani dal nostro, come un occhio – il nostro o quello di Galilei – che scruta gli abissi siderali (tratto da “Conversazione con Remo Anzovino”, domanda 5). Il solo dell’armeno Vardan Grigoryan sono le scale, il ritmo e la storia del suo popolo, entra a metà del brano per dire che tutti, dai luoghi più diversi, possiamo vedere nel cielo le stesse stelle, provare le medesime emozioni, la stessa solitudine. E immaginare Galilei che, come noi, le osserva oggi in un mondo – il nostro – diverso dal suo, in cui i sentimenti, i desideri, le paure cambiano forma, ma non la sostanza.